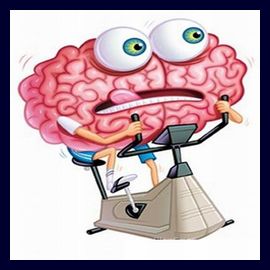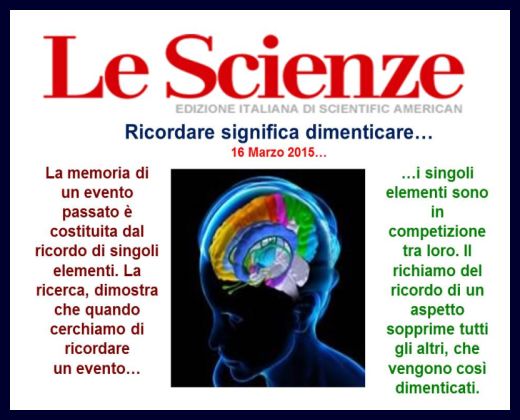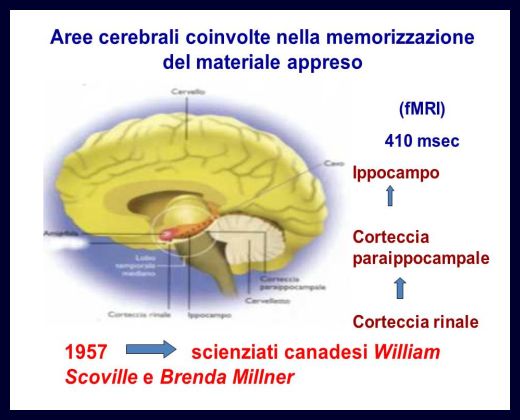|
News
Neuroscienze, Epigenetica e PNEI
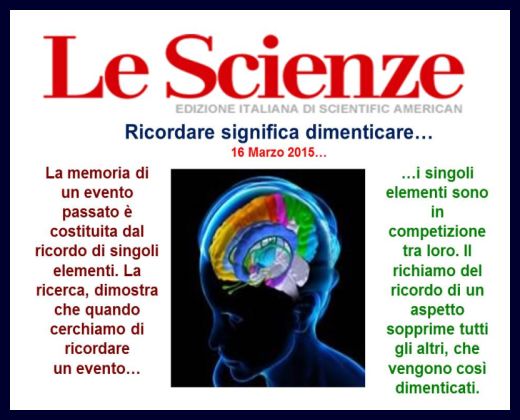
La
memorizzazione di qualcosa avviene dopo che, una serie di
informazioni provenienti dalle sollecitazioni sensoriali, attraversa
le zone deputate del sistema nervoso (Ippocampo e zone limitrofe),
passa per l’ufficio postale che smista la corrispondenza (il Talamo)
e viene proiettata nella corteccia cerebrale.
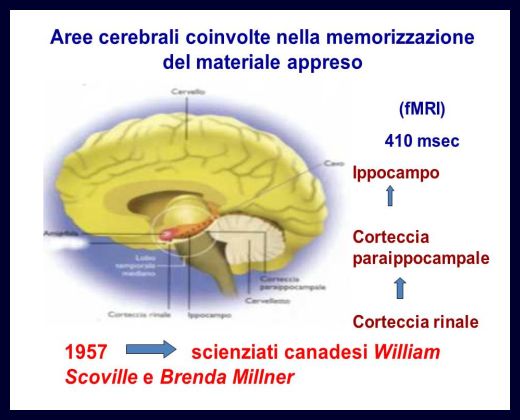

Qui,
prima di entrare nell’armadio dove diventeranno “ricordi”,
le informazioni percepite, vengono confrontate con quanto, di simile,
abbiamo già in memoria. Una volta riconosciute come qualcosa
di noto (eventualmente da migliorare) o come elemento nuovo (da
archiviare per accrescere le nostre conoscenze) vengono, prima
scomposte nei loro costituenti fondamentali (un po’ come un albero di
Natale spogliato dei suoi arredi) e, poi, allocate in diversi punti
fra cui il cervelletto e la corteccia cerebrale definita
“associativa” (perchè è capace di associare
gli elementi pervenuti fin lì, attraverso varie vie
sensoriali: ottiche, acustiche, olfattorie, etc.).
Quando
si rievoca un ricordo, si compie, sostanzialmente, un percorso a
ritroso per cui, una sollecitazione (che stimola il bisogno di
ricordare) richiama dalle zone di memoria, tutti i dati inerenti a
ciò che serve per ricostruire il film della storia che
vogliamo riprodurre.
Siccome,
però, quello che dobbiamo rievocare è composto da tante
tracce mnestiche (per esempio, ne esiste una per ogni via
sensoriale), un meccanismo cerebrale di controllo, permette di far
emergere una singola traccia mnestica inibendo tutte quelle che
potrebbero competere con essa.
Questo
non deve apparire affatto strano.
Infatti,
ognuno di noi, ad esempio, usa maggiormente un senso (la vista,
l’olfatto. Il gusto, l’udito o il tatto) rispetto agli altri per cui,
anche quando dobbiamo ripescare i dati dall’archivio prevarrà
il “file” sensoriale corrispondente. Inoltre, ogni volta
che ripeschiamo ricordi, abbiamo comunque, l’esigenza (consapevole o
meno) di provare a percepire maggiormente la rievocazione di qualcosa
rispetto ad altto (il profumo di un piatto di spaghetti, piuttosto
che il sapore; la freschezza di un bicchiere d’acqua, piuttosto che
la consistenza; il sapore di un dolce, la vista di un tramonto,
etc.).
Lo
studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di
Birmingham e dell’Università di Cambridge pubblicato
su “Nature
Neuroscience"
ha,
ora, dimostrato che il degradarsi dei ricordi è un fenomeno
fisiologico, dovuto proprio al richiamare ripetutamente la memoria di
un evento.
In
sintesi, ricordare è uno dei meccanismi per cui si dimentica.
“Generalmente,
si ritiene che pensare o dimenticare siano processi passivi: la
nostra ricerca rivela che le persone sono più coinvolte di
quanto ritengano nel dare forma a ciò che ricordano della
propria vita”,
ha commentato Michael Anderson, autore senior dello studio. “L’idea
che l’atto stesso di ricordare possa causare l’oblio è
sorprendente, e ci può fornire utili indicazioni sui
meccanismi che controllano la memoria selettiva e sui fenomeni di
creazione di falsi ricordi”
Quanto
scoperto potrebbe spiegare, sperimentalmente anche il perchè,
nel tempo, modifichiamo il ricordo di qualcosa pur restando convinti
di possederne, ancora, lo “stampo originale”.
Gli
spazi lasciati liberi dal meccanismo sopra descritto, infatti,
vengono gradualmente riempiti da nuove esperienze similari che,
quotidianamente, viviamo.
Così,
un po’ alla volta, i nostri ricordi si plasmano rispetto a quanto
(impercettibilmente ma continuamente) cambia la nostra identità

Giorgio
Marchese – Medico
Psicoterapeuta, Docente di Psicologia Fisiologica,
Psiconeuroimmunoendocrinologia ed Epigenetica c/o la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico SFPID (Roma,
Bari, Rimini)
|